 Via Dottula - 6010 - 70122
Via Dottula - 6010 - 70122
 lunedì-giovedi/sabato 10.00-13.00 sabato 17.00-20.00 domenica 10.00-14.00
lunedì-giovedi/sabato 10.00-13.00 sabato 17.00-20.00 domenica 10.00-14.00

 +390805210064
+390805210064

 museobari@odegitria.bari.it
museobari@odegitria.bari.it
Costeggiando il fianco sinistro della Cattedrale, dopo aver superato la Trulla e aver attraversato la piccola piazza intitolata agli arcivescovi Bisanzio e Rainaldo, si giunge nella piccola e stretta Strada Ronchi. Appena imboccata si scorge un portone in legno che dà accesso a una grande corte, di forma triangolare. Il visitatore viene introdotto in uno spazio che appare privato e tranquillo chiuso sui tre lati a nord dal prospetto della Cattedrale a ovest dal palazzo arcivescovile e a sud-est da edifici di minor pregio architettonico. Il prospetto del Palazzo Arcivescovile (che dal 1610 ospita anche il Seminario) si presenta molto diverso rispetto alla sua configurazione originaria. Nel corso del XVIII secolo, infatti, l'Arcivescovo Muzio Gaeta Iuniore affidò all'architetto napoletano Domenico Antonio Vaccaro il compito di ristrutturare e ammodernare la facciata del Seminario. L'aspetto attuale rispecchia appieno il gusto barocco risalente a quei lavori, che, fortunatamente, non sono stati rimossi dai restauri degli anni '60 del secolo scorso. Il prospetto di quattro piani presenta nella parte centrale un ampio loggiato scoperto chiuso ai lati da due corpi di fabbrica che sopravanzano mentre resta arretrata la parte centrale che fa da fondo al loggiato. Questo è chiuso, nella parte antistante da un parapetto su cui poggiano una teoria di archi di forme alternate. I primi, a tutto sesto, sono inquadrati da due lesene che reggono una leggera cornice, i secondi, dalle forme mistilinee e con una luce più ampia, reggono nella parte superiore busti scultorei. Al centro si apre un arco dalla composizione più articolata che segna simmetricamente l’intero prospetto.
Le aperture del Palazzo sono incorniciate da decorazioni in stucco di gusto barocco, in particolare quelle del secondo livello sono caratterizzate nella parte superiore da un cornice al di sotto della quale campeggia un grande fregio. Meno elaborate sono le aperture del terzo piano che hanno una trabeazione modanata lineare ma che presentano comunque un partito decorativo in stucco con due leggere volute poste ai lati degli stipiti. L’intero prospetto è chiuso nella parte superiore da un alto cornicione che corre lungo tutto il profilo dell’edificio.
I restauri degli anni ’60 hanno lasciato a vista la muratura del primo piano che si affaccia sulla terrazza. Questo consente di avere un’idea del prospetto originario del palazzo prima delle trasformazioni barocche. È chiaramente visibile una sequenza di alte arcate cieche binate a tutto sesto con ghiera centinata intervallate da formelle smaltate che richiamano un chiaro linguaggio romanico. Il prospetto originario del palazzo si andava a collocare ortogonalmente al fianco della Cattedrale (vedi scheda) di cui ne era parte integrante. L’intervento settecentesco del Vaccaro non modifica le fabbriche nel loro assetto strutturale limitandosi ad un intervento di ridisegno del prospetto adeguandolo al gusto contemporaneo. Una colonna in granito è posta in posizione decentrata rispetto all'ingresso del Palazzo e accoglie sulla sommità una statua raffigurante San Sabino.
A sud-est il cortile è chiuso da un edificio ad un piano che attualmente ospita alcuni uffici della Curia che presenta un apparato decorativo più semplice rispetto al Palazzo ad evidenziarne la diversa gerarchia. Oltre agli edifici ancora destinati al vescovado, il Palazzo accoglie in alcuni ambienti il Museo diocesano al quale si accede dalla vicina Via dei Dottula.
Dall’aeroporto internazionale Karol Woityla di Bari prendere Viale Enzo Ferrari in direzione di Strada Provinciale 204/Viale Gabriele d'Annunzio/SP204. Prendi Viale Europa e Via Napoli in direzione di Via S. Francesco D'Assisi a Bari. Entrare in SS 16 e prendere l’uscita 4 verso Bari centro/porto. Continuare su via Napoli e poi su via San Francesco d’Assisi. Guidare in direzione di piazza Federico II di Svevia.
Prendere E843, Viale Giuseppe Tatarella e Sottovia Giuseppe Filippo in direzione di Via Napoli a Bari. Continuare su via Napoli e guidare in direzione piazza Federico II di Svevia.
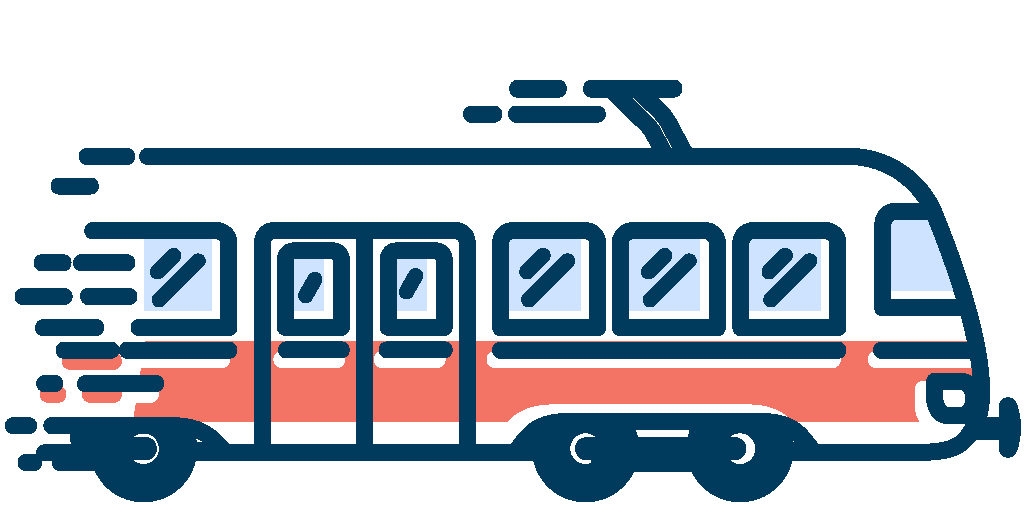 MEZZI
MEZZI
Arrivano nelle vicinanze le linee AMTAB 3-12-12/-21-35
Piazza Massari-Piazza Federico II di Svevia-Piazza Prefettura