 Strada Santa Chiara - 6010 - 70122
Strada Santa Chiara - 6010 - 70122


 +390805242244
+390805242244





All'incrocio delle Strade Tresca e Santa Chiara, in un'area prospiciente il castello svevo, è situata la chiesa di Santa Chiara. L’edificio era ubicato a ridosso delle mura cittadine, abbattute agli inizi del ‘900, che, partendo dal castello cingevano il borgo antico. Sul lato sud si erge il campanile della chiesa antistante il prospetto della chiesetta di San Giovanni Crisostomo (vedi scheda). In origine la chiesa era dedicata a Santa Maria Theotonicorum, edificata nel XII secolo, a devozione dei numerosi pellegrini germanici che attraversavano la Puglia diretti in Terra Santa. Nel 1492 la sua titolazione cambiò diventando Santa Chiara e fu affidata alle clarisse. Non ci sono fonti che permettono di ipotizzare la forma originaria della chiesa, si sa però che nel XVIII secolo essa venne completamente trasformata assumendo l’aspetto attuale. L'esterno è in tufo lasciato a vista e un basamento in pietra calcarea. Il prospetto termina con una cuspide segnata da una cornice che corre lungo tutto il profilo al di sotto della quale, a quote diverse, si aprono due finestroni. Il più alto, di minori dimensioni e di forma mistilinea, è segnato da una leggera cornice aggettante, al pari del finestrone sottostante. La forma di entrambe le aperture richiama i caratteri del tardo barocco presente in molti altri esempi di questo periodo. Un portale in pietra calcarea dalle linee sobrie è opera dei restauri avvenuti nel 1934 e presenta nella parte superiore un timpano spezzato che richiama in forme moderne un linguaggio vagamente barocco. Il fianco meridionale ripropone i materiali della facciata con quattro semplici finestroni a tutto sesto nella parte alta incassati nella muratura.
Sullo spigolo sud-est dell’edificio s’innalza il campanile, opera degna di attenzione per il partito architettonico che lo connota. I quattro ordini attuali mancano della parte superiore che terminava con una cupola a “cipolla” presente ancora nel 1886 come si vede in una veduta di Bari realizzata da Ambrogio Correnti. I primi tre ordini sono caratterizzati da prospetti leggermente concavi definiti sugli spigoli da paraste che presentano un motivo a fasce alternate. All’interno delle specchiature si aprono finestroni più ampi nel secondo e terzo livello e di minore dimensione nella parte alta del primo livello. Le cornici delle aperture si presentano più articolate nei livelli superiori mentre in basso viene proposta una forma più semplice con un arco molto ribassato e dalla forma sinuosa. Il quarto livello si discosta da quelli sottostanti per stile e dimensione. Quattro lesene binate, che poggiano su un basamento continuo, terminano con capitelli compositi che reggono una cornice fortemente aggettante. All’interno della specchiatura tra le lesene si aprono finestroni a tutto sesto con balaustre a pilastrini.
La ricchezza dell’interno contrasta con la semplicità dei prospetti, fatta eccezione per il campanile. La chiesa è a navata unica e sui lati lunghi si aprono otto cappelle sormontate da archi a tutto sesto, all’interno delle quali sono collocati altrettanti altari. Al di sopra degli archi, gelosie in legno dalla forma bombata ospitavano le monache che potevano assistere alle celebrazioni senza essere viste. Il ritmo delle cappelle è scandito da paraste di ordine gigante con capitelli compositi in stucco su cui corre un’alta trabeazione dello stesso materiale. Questa è interrotta dalla cantoria sulla contro facciata che accoglie un organo celato alla vista da una rosta che richiama la forma delle gelosie alloggiate sulle cappelle.
Sul lato est, la trabeazione si deforma in una voluta che circonda la parte superiore dell’alto postergale marmoreo (la parte retrostante dell’altare), ubicato in Cattedrale fino al 1935, con un effetto scenografico di grande suggestione. L’altare, in marmi policromi intarsiati, è datato da una epigrafe al 1757, ciò induce a ritenere che l’opera possa essere attribuita all’architetto Domenico Vaccaro, attivo in città in quegli anni. Il presbiterio è delimitato da una balaustra dall’andamento sinuoso che proviene anch’esso dalla Cattedrale di Bari. Una volta a padiglione con ampi finestroni e fondo piano è arricchita da decorazioni e stucchi mentre il pavimento è in marmo in sostituzione di quello originario settecentesco in maioliche invetriate. L’importante apparato pittorico della chiesa, per lungo tempo custodito all'interno del Museo Diocesano, è stato ricollocato in situ durante gli ultimi restauri. Sono da notare, in particolare, i due dipinti ai lati dell’altare dell'artista inglese Fabris del XVIII secolo in cui sono raffigurati a sinistra San Francesco d'Assisi che sorregge una croce e a destra, Sant'Antonio da Padova con in braccio Gesù bambino. Di Andrea Miglionico, è la tela centrale del soffitto dove sono rappresentati i Santi in Gloria e, sempre sul soffitto, la tela di Nicola Gliri raffigurante Il Transito di Santa Chiara.
Da viale Enzo Ferrari continuare in direzione di Strada Provinciale 204/Viale Gabriele d'Annunzio/SP204. Prendere Viale Europa, SS16, Via Napoli e Corso Vittorio Veneto in direzione di Via Venezia a Bari. Seguire Via Venezia e Largo Papa Urbano II fino a Piazza S. Nicola.
Da casello Bari Sud dell’autostrada A14 prendere E843, Viale Giuseppe Tatarella, Sottovia Giuseppe Filippo, Via Brigata Regina e proseguire su Corso Antonio de Tullio in direzione di Via Venezia a Bari. Seguire Via Venezia e Largo Papa Urbano II fino a Piazza S. Nicola.
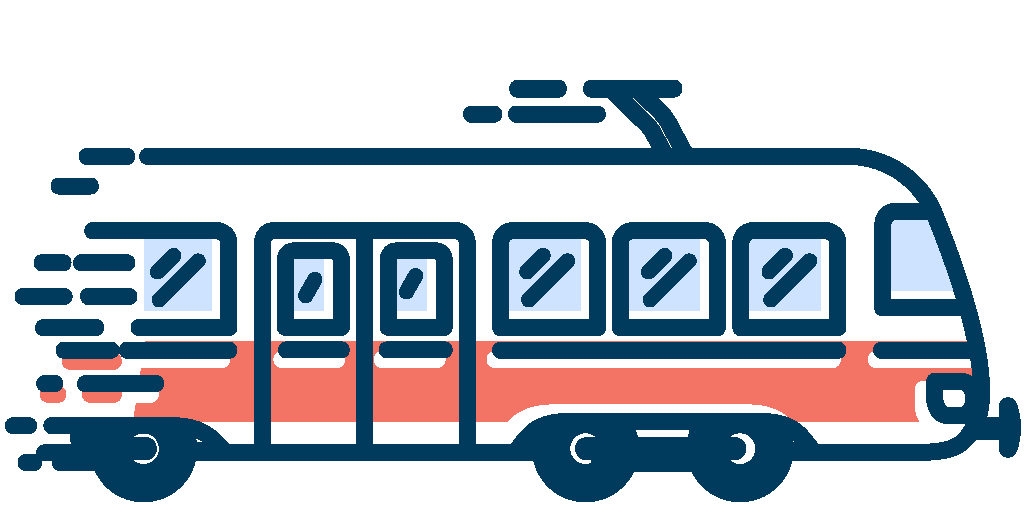 MEZZI
MEZZI
Arrivano nelle vicinanze di Largo Abate Elia le linee AMTAB A (area sosta Piazza Massari)- 2/-10-12/-35.
Lungomare Imperatore Augusto-Area Parcheggio Museo Archeologico