 Piazza San Nicola - 6010 - 70122
Piazza San Nicola - 6010 - 70122



 Gratuito -
Gratuito -




La chiesa di S. Gregorio, edificata sul finire del X sec., sorgeva, insieme ad altri edifici di culto (i documenti ricordano le chiese greche di S. Eustrazio, S. Nicola, S. Giovanni Evangelista) e a strutture civili (Pretorio, corpo di guardia, ecc.) all’interno del recinto fortificato che costituiva la sede governativa del Catapano Bizantino (Tema di Longobardia). Tutta l’area fu distrutta sul finire dell’XI secolo quando i nuovi dominatori Normanni la cedettero alla città per far posto alla costruzione della nuova Basilica dedicata a San Nicola (vedi scheda), le cui ossa erano state da poco trafugate dalla città di Myra in Licia, nell’odierna Turchia, di cui Nicola fu Vescovo. Il prospetto principale, che si affaccia su piazzetta 62 Marinai, è tripartito da due lesene concluse da cimase. La parte centrale cuspidata si eleva oltre gli spioventi dei due lati corrispondenti alle navatelle laterali. Nella porzione centrale si apre un ampio portale di ingresso con arco a tutto sesto, al di sopra del quale sono presenti tre monofore centinate con cornici a grani di rosario. Sotto il timpano che conclude la facciata, incorniciato da mensole con motivi floreali e animali, si trova un finestrone la cui specchiatura e caratterizzata da una doppia coppia di bifore poste su due livelli sovrastanti. Nelle fasce laterali del prospetto sono collocati due portali minori, con arco a tutto sesto con doppia ghiera lunata, che consentivano l’accesso alle navate laterali e che furono parzialmente chiuse nel ‘600 per la realizzazione di due altari all’interno. Al di sopra dei portali sono collocate due monofore con cornice modanata chiuse da transenne in pietra lavorata a traforo. La parte absidale ripete il motivo tripartito della facciata sottolineato dalle tre absidi con copertura in lastrine di pietra calcarea (chiancarelle). Sulle due absidi laterali si aprono strette monofore, mentre in quella mediana, di maggiori dimensioni, è presente una più ampia monofora contornata da una cornice a grani di rosario. Il prospetto sud (quello nord è occluso da edifici addossati) presenta in un doppio ordine corrispondente alla differenza di altezza tra la navata laterale e quella centrale. Nella parte superiore (cleristorio) si aprono tre monofore che danno luce dall’alto alla navata centrale mentre più in basso quattro monofore danno luce alla navata laterale. In posizione leggermente decentrata un portale con ghiera lunata preceduto da una scala in pietra, fa da accesso laterale alla chiesa. La presenza della scala sottolinea il forte dislivello tra la quota di calpestio interno rispetto all’attuale piano stradale. Un piccolo campanile fu abbattuto durante i restauri, degli anni trenta del Novecento. Scolpite sulle pareti esterne si possono leggere undici iscrizioni funerarie riferite a personaggi i cui sepolcri erano posti a ridosso delle mura. Durante i secoli vennero addossate alla chiesa diverse fabbriche che ne hanno occultato parti consistenti fino ai radicali interventi di restauro del 1928. In questa fase si provvide a liberare il lato sud e le absidi dalle superfetazioni. In particolare fu demolita la grande cisterna per la raccolta delle acque piovane che si addossava alle absidi e i corpi di fabbrica che chiudevano la piazza addossandosi alla torre di sinistra della Basilica di San Nicola.
L’interno è a tre navate separate da quattro colonne e un pilastro centrale con semi colonne addossate su cui si impostano sei archi a tutto sesto che poggiano su piedritti che ne esaltano lo slancio verso l’alto. I capitelli sono di reimpiego di epoca altomedievale (VII-VIII-XI sec.) e sono caratterizzati da motivi vegetali e antropomorfi. Sui capitelli delle semicolonne addossate ai pilastri sono raffigurate figure leonine separate da un volto umano. La diversità degli stili e delle datazioni dei capitelli e delle colonne fa ritenere che ci si trovi di fronte non alla chiesa originaria di San Gregorio della fina del X sec. citata nei documenti bizantini, ma a un rifacimento più tardo del XII sec., ricostruita probabilmente dopo le distruzioni che la città subì ad opera di Guglielmo il Malo nel 1156. Al centro dell’abside è posto un crocifisso ligneo dipinto del ‘600. La copertura della navata centrale è a capriate che originariamente sostenevano un controsoffitto in legno dipinto. Tra il XVII e il XVIII sec. l’edificio assunse una veste barocca con l’inserimento di altari, cappelle laterali, immagini e nicchie, provocando lesioni alle strutture. Ulteriori interventi furono realizzati nell’800 quando fu creata un’apertura sulla porta principale che dalla cantoria in legno immetteva sul terrazzo. Con i lavori del 1927 furono rimossi gli altari barocchi di Sant’Antonio, S. Biagio e S. Vito, nella navata sinistra, e quello del Carmine, nella navata destra, sostituite le capriate, fu chiusa la porticina di accesso al terrazzo, fu demolito il campanile, riaperte le monofore della navate minori e riportare alle dimensioni originarie le sei monofore della navata centrale.
Da viale Enzo Ferrari continuare in direzione di Strada Provinciale 204/Viale Gabriele d'Annunzio/SP204. Prendere Viale Europa, SS16, Via Napoli e Corso Vittorio Veneto in direzione di Via Venezia a Bari. Seguire Via Venezia e Largo Papa Urbano II fino a Piazza S. Nicola.
Da casello Bari Sud dell’autostrada A14 prendere E843, Viale Giuseppe Tatarella, Sottovia Giuseppe Filippo, Via Brigata Regina e proseguire su Corso Antonio de Tullio in direzione di Via Venezia a Bari. Seguire Via Venezia e Largo Papa Urbano II fino a Piazza S. Nicola.
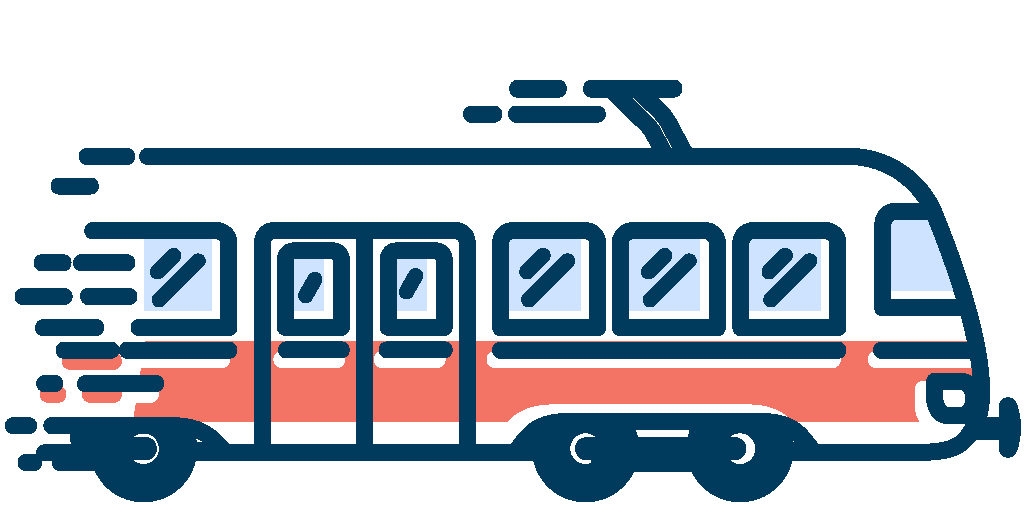 MEZZI
MEZZI
Arrivano nelle vicinanze di Largo Abate Elia le linee AMTAB A (area sosta Piazza Massari)- 2/-10-12/-35.
Lungomare Imperatore Augusto-Area Parcheggio Museo Archeologico
Questo sito utilizza cookie. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all' uso dei cookie. maggiori informazioni